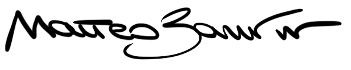Recensione: “L’abbazia di Northanger”, di Jane Austen
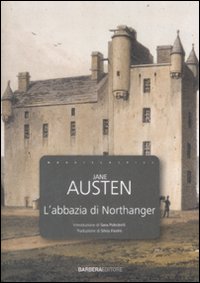 Nonostante Jane Austen abbia posto l’ultimo punto a L’Abbazia di Northanger nel 1799, questo breve, affascinante romanzo vide la luce solamente nel 1818, dopo la morte dell’autrice. La fantasia di Catherine, divoratrice di romanzi gotici – in particolar modo, quelli della famosa Ann Radcliffe – riesce ad esprimersi particolarmente tra le mura dell’abbazia: è qui, infatti, che la fanciulla si lascia rapire all’idea di un efferato assassinio compiuto dal Generale Tilney, padre di Henry.
Nonostante Jane Austen abbia posto l’ultimo punto a L’Abbazia di Northanger nel 1799, questo breve, affascinante romanzo vide la luce solamente nel 1818, dopo la morte dell’autrice. La fantasia di Catherine, divoratrice di romanzi gotici – in particolar modo, quelli della famosa Ann Radcliffe – riesce ad esprimersi particolarmente tra le mura dell’abbazia: è qui, infatti, che la fanciulla si lascia rapire all’idea di un efferato assassinio compiuto dal Generale Tilney, padre di Henry.
Dopo un susseguirsi di equivoci e di peripezie, Catherine sarà costretta ad abbandonare Northanger, con la convinzione di aver perduto, per sempre, la possibilità di essere felice. Sebbene il titolo possa trarre in inganno, non si tratta di un romanzo gotico, bensì di una pungente e ironica satira di quel genere letterario tanto in voga all’epoca. Nonostante ciò, il romanzo sviluppa moltissimi temi cari alla letteratura criticata dall’autrice.
Le vicende del romanzo si suddividono in due grandi sezioni: la prima ha come cornice la città di Bath (le sue sale da thé, i saloni da ballo e da gioco, le aperte campagne); qui, Catherine Morland, la giovane protagonista, intesserà le sue prime, vere relazioni extra-familiari. In particolar modo, nascerà del tenero tra lei e Mr Henry Tilney, un giovane affascinante. A Bath si intrecciano i fili del Destino dei personaggi che seguiremo anche durante la seconda parte del romanzo, quando la scena di sposterà all’interno di una vera abbazia medievale gotica, la stessa che dà il nome al romanzo: Northanger è la residenza della famiglia Tilney.
Questo romanzo ha la particolarità (unica nel panorama letterario austeniano) di contenere in sé tutti i topoi caratteristici del filone gotico, tra cui la condizione di terrore psico-fisico, gli eventi sovrannaturali, i castelli diroccati e antichi e gli elementi dell’arabesco. Nel corso della storia, l’eroina sarà spaventata da temporali e tempeste (che ricordano moltissimo quelle contenute ne I misteri di Udolpho), candele che si spengono al soffio del vento e luoghi sinistri e bui, che vanno a costituire un vero e proprio labirinto piranesiano. Soltanto alla fine, Catherine, maturata e consapevole – come in ogni romanzo di formazione che si rispetti – comprenderà che le fantasie devono essere confinate nei libri e sceglierà di vivere.
Ho sempre pensato con tenerezza a questo romanzo e a questa insolita eroina austeniana: una storia, quella di Catherine, in cui è possibile immedesimarsi; un classico immortale della penna più dotata e amata di tutta l’Inghilterra.
Pubblicato il 12 novembre 2014 su inkbooks